
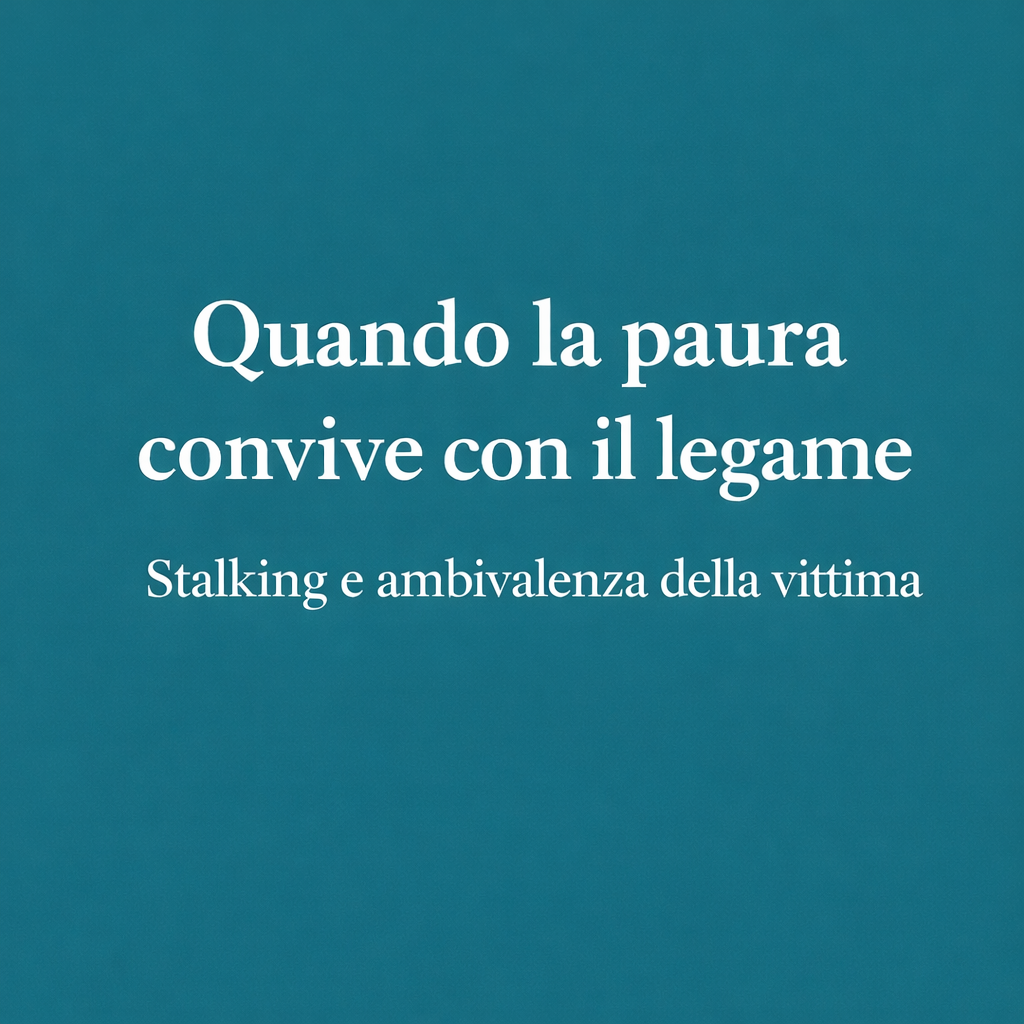
Può esistere il reato di atti persecutori anche quando la vittima continua a frequentare l'autore delle condotte, mantiene contatti con lui o manifesta atteggiamenti apparentemente contraddittori?
È una domanda tutt'altro che teorica, che ricorre spesso nei procedimenti per stalking e che alimenta, non di rado, fraintendimenti sia sul piano difensivo sia su quello della tutela della persona offesa.
La risposta fornita dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 247 del 5 gennaio 2026, è chiara e merita attenzione proprio perché affronta il problema senza semplificazioni astratte, ma calandolo nella complessità delle relazioni violente.
Il delitto di atti persecutori, disciplinato dall'art. 612-bis c.p., punisce chiunque, mediante condotte reiterate di minaccia o molestia, cagioni nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine, oppure la costringa ad alterare le proprie abitudini di vita.
Si tratta di un reato abituale, che richiede la reiterazione delle condotte, ma non necessariamente una loro protrazione nel tempo particolarmente lunga: anche pochi episodi, purché autonomi e significativi, possono essere sufficienti a integrare la fattispecie. Centrale, più che il numero degli atti, è la loro idoneità a produrre uno degli eventi tipici previsti dalla norma.
È all'interno di questo quadro normativo che si colloca la vicenda esaminata dalla Corte. Il caso prende le mosse da una relazione sentimentale segnata, sin dalle sue fasi iniziali, da dinamiche di controllo, gelosia e sopraffazione.
Le condotte contestate all'imputato si sono sviluppate in un arco temporale non particolarmente esteso, ma caratterizzato da una progressiva escalation: controllo ossessivo del telefono della compagna, richiesta delle password dei social network, aggressioni fisiche innescate da sospetti di tradimento, fino a episodi di violenza conclamata che avevano provocato lesioni visibili. In uno degli episodi più gravi, la donna veniva colpita al volto alla presenza di terzi; in un altro, l'imputato si recava sul luogo di lavoro della vittima pretendendo di riallacciare la relazione, per poi aggredirla e appropriarsi del suo cellulare.
È proprio a questo punto che il dato fattuale si intreccia con una delle questioni più delicate in materia di stalking: il comportamento della persona offesa successivo o parallelo alle condotte persecutorie. La difesa aveva infatti valorizzato alcuni elementi apparentemente incompatibili con l'esistenza di un "fondato timore per l'incolumità", sostenendo che la donna avesse continuato a frequentare l'imputato anche dopo episodi violenti e che avesse mantenuto contatti telefonici con lui persino durante l'applicazione di una misura cautelare. Secondo questa impostazione, tali condotte avrebbero dimostrato l'assenza di un reale stato di paura.
Ebbene, la Corte di Cassazione respinge nettamente questa lettura, ma lo fa con una motivazione che va ben oltre la mera affermazione di principio. I giudici di legittimità riconoscono infatti un dato spesso trascurato: nelle relazioni affettive connotate da violenza e controllo, il timore per la propria incolumità non si manifesta necessariamente in modo lineare, continuo e privo di ambivalenze.
Al contrario, può coesistere con sentimenti contrastanti, con tentativi di recupero del rapporto, con gesti di apparente disponibilità che non elidono, ma anzi spesso accompagnano, uno stato di soggezione e paura.
È in questa prospettiva che la sentenza valorizza la fase finale della relazione, quando il rifiuto della vittima di proseguire il rapporto rende il timore più evidente nella sua dimensione giuridica.
I comportamenti precedenti, inclusi quelli che potrebbero apparire come segnali di acquiescenza o di riavvicinamento, vengono letti come parte integrante di una dinamica relazionale complessa, non come indici di inattendibilità o di insussistenza del reato.
A rafforzare questa ricostruzione contribuiscono anche gli elementi sintomatici emersi dalle testimonianze dei familiari, che descrivono una donna impaurita e limitata nella propria libertà di movimento.
Da questa impostazione discende un principio di grande rilevanza pratica: la frequentazione dell'autore delle condotte, o il mantenimento di contatti con lui, non esclude di per sé la configurabilità del reato di stalking. Ciò che rileva è l'effetto complessivo delle condotte sulla sfera psicologica e sulle abitudini di vita della vittima, non la coerenza apparente delle sue reazioni.
Non meno significativa è la risposta fornita al profilo relativo all'elemento soggettivo del reato.
La Corte ribadisce che lo stalking richiede il dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di porre in essere comportamenti vessatori idonei a produrre gli eventi tipici previsti dalla norma. In presenza di condotte violente, intrusive e reiterate, l'asserita ambiguità del comportamento della persona offesa non è idonea a escludere tale consapevolezza.
Le ricadute pratiche di questa impostazione sono rilevanti tanto per la persona offesa, cui viene riconosciuta una tutela aderente alla realtà delle relazioni violente, quanto per la difesa dell'imputato, chiamata a confrontarsi con una valutazione complessiva delle condotte e del loro impatto concreto. La sentenza n. 247 del 2026 conferma così un approccio rigoroso ma realistico all'accertamento del reato di atti persecutori, capace di tenere insieme il dato normativo e la dimensione relazionale dei fatti, offrendo agli operatori del diritto uno strumento interpretativo prezioso per affrontare una materia complessa e in continua evoluzione.



